Jannacci iniziò principalmente come musicista, suonando il pianoforte per cantanti diversi, nella scrittura dei testi ha alternato canzoni demenzial-fantasiose (sull’onda di F.Buscaglione) a canzoni socialmente impegnate con protagonisti soggetti marginali, i quali vengono amplificati PROPRIO dalle incertezze e dalla parlata incespicante di Jannacci…..
Fosse stato un fine cantante precisino, avrebbe reso inverosimile i soggetti cantati…
Il concetto viene così espresso ..Qui
“..Caratteristica comune alle canzoni di Enzo che non rinunciano mai a contaminare il tragico col comico, giocando spesso, con maestria, su un crinale al limite tra i due elementi. Jannacci che, come l’amico Gaber e come Fabrizio De André ha passato una vita intera a gettare uno sguardo mai pietistico, ma semmai partecipe e commosso su tutta una parte di umanità che ora fa fine definire “gli ultimi” e che in tempi di sbornie ideologiche si etichettavano come “lumpenproletariat”: i reietti, i marginali, le persone che, normalmente non arrivano alla gloria di una canzone tutta per loro. Personaggi che, come dice lo stesso Jannacci, non sono di ieri, non risalgono agli anni ’50, ma in alcuni casi rimontano il tempo all’indietro fino ad arrivare alla prima guerra mondiale. Personaggi che vivono di piccolo e piccolissime cose: “Un dì lü l’avea menada a veder la Fiera/
la gh’eva un vestidin color del trasú / disse: “vorrei un krapfen… non ho moneta”/ “Pronti!” El gh’ha dà dés chili… e l’ha vista pü!” (Andava a Rogoredo). “Rivò un bel dì che era l’otto d’Agosto/ con la cravatta colore rosso/ Chissà perché, che io m’ero illusa /che mi volesse parlare d’amor!” (Chissà se è vero). “Lesto si avvia, con la cartella sotto il braccio/ male annodata la cravatta dell’Upim…” (Prendeva il treno). “Sporchi ancora del sudore / del lavoro appena smesso” (Qualcosa da aspettare). “Sia ben chiaro che non penso alla casetta/ due locali più i servizi, tante rate, pochi vizi” (Quella cosa in Lombardia). “Fu quando gli zingari arrivarono al mare che la gente li vide, che la gente li vide come si presentano loro, loro, loro gli zingari, come un gruppo cencioso, così disuguale e negli occhi, negli occhi impossibile, impossibile poterli guardare” (Gli zingari). “Giovanni telegrafista e nulla più / stazioncina povera c’erano più alberi e uccelli che persone / ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione / battendo, battendo su un tasto solo” (Giovanni Telegrafista). Un campionario di ultimi, di reietti, di barboni, di gente cunt su i scarp del tennis, ma visto dall’interno. Non è l’abito, è la fodera. Jannacci indossa i suoi personaggi e se ne fa voce e questa voce è straziata, spezzata, incerta e balbettante. La vera innovazione di Enzo Jannacci è nella voce con cui canta le sue storie. Credo lo abbia detto anche Umberto Eco e concediamoci il lusso di concordare. Un Jannacci che cantasse “pulito”, come si dovrebbe fare, non sarebbe lui e non riuscirebbe a inserire tanta forza drammatica, come ne mette nei suoi urlati, nei suoi “fortissimo”, nelle sue balbuzie o esitazioni. È un canto “disperato” che ridà voce ai disperati. ..”
Come accaduto al suo socio di inizi Gaber, ad un certo punto della carriera discografica, il produrre musica e venderne non riusciva a coprire l’intera parabola creativa di questi artisti, come se la musica e la canzone fosse riduttiva rispetto alle loro necessità d’espressione, fosse un mezzo troppo sintetico..ristretto…mediato.
Entrambi, si rivolsero ad altro….Gaber svilupperà il genere del cosiddetto TEATRO-CANZONE in cui s’alternano monologhi e canzoni scritti entrambi dallo stesso Gaber..che per una trentina d’anni porterà in giro per teatri italiani..
Per Jannacci si aprirà negli anni settanta una parentesi di collaborazioni musical-artistiche con il cinema…con la composizione di diversi temi originali per films italiani .
Biografia
Sul piano musicale vanno rilevate le esperienze come compositore di colonne sonore per il cinema: “Romanzo popolare” di Mario Monicelli, “Saxofone” di e con Renato Pozzetto, “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmuller” (che nel 1977 gli vale una nomination all’Oscar come miglior colonna sonora), e “Piccoli equivoci” di Ricky Tognazzi.
Come autore e arrangiatore collabora con Mina (per l’album “Mina quasi Jannacci”, nel 1977) e con Milva (per il disco “La rossa” nel 1980).
Nel 1979, in occasione dell’uscita dell’album “Fotoricordo” (uno dei suoi dischi migliori), realizza un programma televisivo, “Saltimbanchi si muore”; sempre nello stesso anno appare come ospite in un concerto di Paolo Conte al Teatro “Pier Lombardo” di Milano, dopo 5 anni di assenza dal palcoscenico (l’ultimo suo concerto risale al 1974).
E’ il preludio ad una tournèe trionfale, del 1981, che parte il 15 Febbraio da un Teatro Tenda montato a San Siro dall’A.R.C.I.: lo accompagnano musicisti come Flaviano Cuffari alla batteria, Dino D’Autorio al basso, Sergio Farina alle chitarre, Gilberto Zilioli alle tastiere, Nando De Luca al pianoforte e alla fisarmonica, Bruno De Filippi alle chitarre e all’armonica, e Pino Sacchetti e Paolo Tomelleri ai fiati.
Tornerà a scrivere canzoni con Cochi e Renato che a metà anni settanta hanno avuto il loro apice di successo televisivo e negli anni ottanta si rituffò nell’attività cantautoriale pubblicando nuovi album e portando in giro diversi recitals .. “Niente domande”, nel 1987 con “Parlare con i limoni” e nel 1988 con “Tempo di pace…pazienza!”.
Intervista del 1995 sulla canzone d’autore, l’ispirazione musicale, l’importanza della vocalità…
-
Secondo lei la canzone d’autore è poesia?
Una volta di una bella canzone si diceva “fa ballare”….
Nanni Ricordi inventò i cantautori: il primo fu Bindi, che suonava la fisarmonica, poi Paoli, che faceva il pittore, Gaber…. Per quanto riguarda la risposta che devo darti… la poesia c’è ovunque. Una volta erano in pochi a capire la poesia… e la medicina. Poi i medici sono ignoranti… Però poi ho scoperto le canzoni di Paolo Conte: un connubio tra testo e musica che non c’è quasi mai. Solo in alcuni brani di Dalla, Guccini… Quelli sono rimasti i capisaldi della canzoni d’autore. Io in particolare sono diventato un cantautore perché le mie canzoni non le voleva cantare nessuno; dovevo cantarmele da me. Molte canzoni dei cantautori hanno un momento di successo interno sublime, ad esempio Dalla quando dice “di così tanti capelli ci si può fidare” o De Gregori “non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore”. Ma ce ne sono tanti altri, Bertoli… ; forse Conte è il più poeta, ma è anche il meno sociale. Io non ho mai avuto delle basi importanti, come De Andrè o Vecchioni: la forza della mia canzone era il canto dei disperati. Si poteva anche cantare i ricchi, i nobili e loro disgrazie, ma allora mi interessava quello con “le scarpe da tennis”, anzi, ancora prima “il meccanico di cappelli” che era una canzone surreale, fattami conoscere da Dario Fo.Infatti a Torino ho intervistato Dario Fo e mi ha detto che in quel periodo vi fu una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i testi. Lei è uscito sulla scia del Cantacronache, si è rifatto alla scuola francese?
Certe soluzioni melodiche, armoniche sono apparentemente della scuola francese. Non voglio essere modesto: ho scritto un pezzo che si chiama Musical, che non faccio quasi mai, in cui ho trovato una simbiosi particolare tra la melodia e ciò che volevo dire. E la gente poi se ne accorge, come La fotografia a Sanremo.In Storia della canzone italiana Borgna riporta una frase di Umberto Eco secondo il quale lei è stato rivoluzionario nell’uso della voce, nel modo di cantare. Quanto conta in una canzone la voce, l’interpretazione?
E’ tutto, soprattutto in pubblico. Se ti presenti al pubblico hai bisogno di comunicare, e questo vale sempre, sia per le cose comiche, grottesche, sia per le cose tragiche, disperate.Lei sembra sempre molto distaccato nelle sue interpretazioni, ha un modo di fare distante, lontano dalle cose che dice…
Questo è il sistema: non deve esserci niente di retorico. Devi tagliare, buttare via tutto quello che c’è di retorico.Guccini mi ha detto che secondo lui tra la canzone e la poesia c’è una grande differenza: la poesia è più elitaria. In questo senso, secondo lei, il testo di una canzone deve avere degli accorgimenti diversi?
Proprio Guccini che è uno dei maggiori poeti che abbiamo… Io ho più di cinquant’anni – più o meno siamo tutti della stessa età – e sono convinto che siamo stati troppo attenti a certe cose, perché avevamo un certo ritegno. Sembrava che il grande pittore il grande architetto, da Renzo Appiano a Giacometti, facessero cose al cui confronto noi sembravamo dei saltimbanchi. Invece non è vero, prendi una canzone di Paoli, una delle prime, “ sassi sono le mie parole”: chiamarla poesia allora era un’eresia. Però è poesia: vale molto di più una canzone che ti tocchi il cuore, che dica delle cose, che migliaia di persone che vanno ad un comizio.Secondo lei trattare la canzone come tema sociale, quindi politico, è una scelta estetica?
Sì, certo. Il più grande è stato Ivan Della Mea: lui ha dedicato la vita alla canzone politica, io lo ammiro molto. In un momento difficile, in cui ce n’era proprio bisogno, in cui noi eravamo un po’ vacillanti, lui e Gaber hanno avuto molto coraggio. Gaber era più portato all’anarchia, a vedere le cose con rabbia e distacco, Ivan invece era una vera e propria dichiarazione di guerra.Lei tratta quasi sempre di temi sociali: lo fa perché la canzone deve anche essere provocazione?
No, provocazione no. La canzone deve lasciar turbati, per le pause, per la melodia, per quello che dici, per come ti senti… Ci sono sere infatti che non mi va di cantare, per qualunque motivo. Non capita solo a me, ma a chiunque abbia un impegno sociale, culturale: se stai bene canti, vai in platea, altrimenti… c’è una frase: “non esistono tutti i pubblici per gli artisti”. Può capitare una sera che non stai bene, che hai dei problemi grossi, e la gente se ne accorge. Io non voglio coinvolgere troppo: mi interessa che ascoltino, che si crei quell’affiatamento, che, quando escono, abbiano capito.Per Ruwet nelle canzoni di Brassens testo e musica, presi separatamente, non hanno nulla di notevole. E’ la loro unione a dare un risultato straordinario… Secondo lei la simbiosi tra questi due elementi è importante?
In Brassens sì. Anche in Conte. Io ci ho messo un anno a scrivere La fotografia, a far collimare decentemente testo e musica. Bisogna ascoltare e ascoltarsi: una cosa non deve svilire l’altra.E’ d’accorto con Zumthor, secondo cui i cantautori possono essere considerati gli ultimi poeti orali?
La poesia è una pozzanghera che io vedo in un certo modo, tu in un altro. Basta che vi sia nostalgia, serenità, una pace che non si riesce a trovare… è questo che dà l’input alla poesia vera e non alla retorica. Non si scrivono poesie: si scrive.Se dovesse definire la canzone d’autore?
E’ un tipo di poesia minore abbinata ad un tipo di dialettica musicale intensa. Sto pensando al pezzo di Dalla quando dice, parafrasando un canzone napoletana, “ti voglio bene, ti voglio bene”. A nessuno viene in mente che sia una cosa che riguarda il suo animo, l’animus romantico, tragico, di questo ex-ragazzo che lanciando questo urlo…
Io non ho mai pensato che No tu no fosse un tipo di poesia di diversi; semmai era un urlo disperato della gente che ho sempre cantato, i disperati, i disadattati, gente che fatica ad andare avanti. Per questo sono d’accordo con Eco ed Eco è d’accordo con me: il diverso è colui per il quale noi siamo diversi.
Io spezzerei una lancia a favore di uno dei nostri più grandi poeti e compositori: Claudio Baglioni. Lui ha abbandonato per scelta di cantare l’amore delle ragazzine, per cantare l’amore per la gente: da I vecchi a Le ragazze dell’Est… Canta benissimo, sa abbinare meglio di noi le cose tra loro. Poi è anche giovane e bello… Pochi ne parlano, invece Claudio ha tanto da dare ancora.Chi erano i suoi modelli, a chi si rifaceva?
Io accompagnavo Sergio Endrigo negli anni Sessanta: suonavo il piano e dovevo pagarmi gli studi in medicina; lui ha avuto la gentilezza di farmi lavorare, di prendermi come pianista per le sue serate. Un giorno capitammo alla Bussola (c’era ancora Bernardini), vidi Gilbert Becaud che provava e pensai: se un giorno dovessi fare quel mestiere, lo vorrei fare come quello lì.Sempre Zumthor sostiene che la canzone è avvantaggiata sulla poesia, perché oggi la poesia è muta. Il successo maggiore della canzone è quindi dato dalla voce…
Gli aedi non potevano fare a meno dell’elemento musicale. Lo stesso Ungaretti, che voleva leggere lui le sue poesie, in una scala di valori molto più alta era un cantautore .Non trova che la poesia oggi si sia allontanata dalla vita quotidiana?
Io sono per la poesia popolare. Che Guevara ha scritto delle cose bellissime. Ci sono poeti in Brasile, a Cuba, che cantano le loro poesie anziché recitarle: la poesia ha bisogno del supporto della musica, ancora oggi. E la gente ha bisogno di queste cose; ci vorrebbero più cantautori, più canzoni di qualità in un mondo dove è imperante il karaoke. Tanto i soldi li guadagni comunque, sia che canti puttanate, sia che fai canzoni belle, di valore.Lei ha scritto molte canzoni in dialetto: è una carenza dell’italiano o ne è un arricchimento?
C’è il problema della comprensione: se io canto le canzoni in milanese a Peschici nessuno capisce un’ ostia; quindi se devo andare a cantare a Sanremo davanti a milioni di telespettatori canto in una lingua che tutti capiscono. Già gli inglesi sono avvantaggiati; se io fossi nato in America No tu no ve la dovevate sorbire per altri quarant’anni…


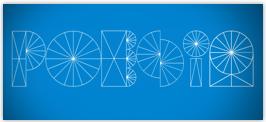



 Il tema della tutela dei beni immateriali (feste, rituali, costumi…) è all’ordine del giorno. L’Italia ha ratificato recentemente la convenzione dell’Unesco del 2003 su questo tema e si appresta a stilare una “lista” nazionale dei beni da valorizzare e tutelare. Mauro Geraci è un antropologo, professore associato di Etnologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina, grande studioso dei cantastorie e cantastorie egli stesso. In questa intervista espone la sua teoria sugli aspetti critici della tutela, sul ruolo del ricercatore antropologo, sulla figura del cantastorie.
Il tema della tutela dei beni immateriali (feste, rituali, costumi…) è all’ordine del giorno. L’Italia ha ratificato recentemente la convenzione dell’Unesco del 2003 su questo tema e si appresta a stilare una “lista” nazionale dei beni da valorizzare e tutelare. Mauro Geraci è un antropologo, professore associato di Etnologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina, grande studioso dei cantastorie e cantastorie egli stesso. In questa intervista espone la sua teoria sugli aspetti critici della tutela, sul ruolo del ricercatore antropologo, sulla figura del cantastorie.